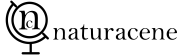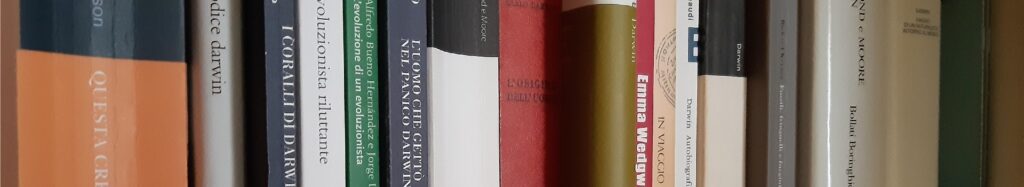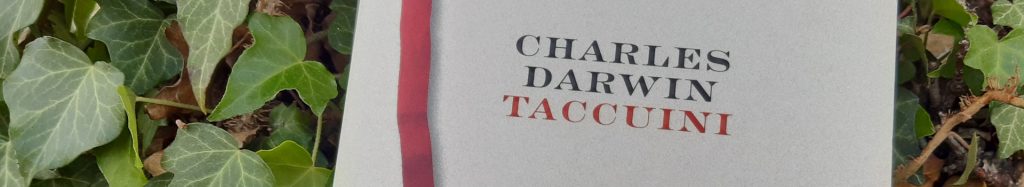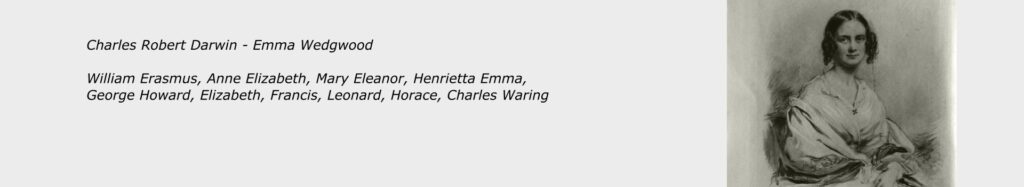Una nuova serie di articoli-report, per meglio comprendere gli attuali cambiamenti climatici ed i probabili scenari futuri
Con “Report climatici” inizia una serie di articoli aventi come principale obiettivo quello di contribuire allo sviluppo delle conoscenze sulle tendenze climatiche che si stanno manifestando in diversi luoghi della Terra.
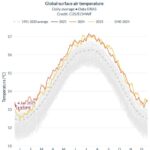
Come tutti oramai sappiamo, i cambiamenti climatici sono parte della nostra vita e sono un problema da contrastare. Il problema è globale e va affrontato in modo globale, acquisendo conoscenze sempre più dettagliate sullo stato del clima e sulle sue tendenze. Va detto sin da subito che i cambiamenti climatici ci sono sempre stati, ma la loro evoluzione non è mai stata così rapida ed intensa come quello attuale. Le cause le conosciamo bene e sono ben descritte in molte pubblicazioni scientifiche e in molti libri, alcuni di questi recensiti in questo sito alla categoria Antropocene.
Documentare il più possibile questi cambiamenti risulta quindi di fondamentale importanza, sia per attuare corrette azioni di mitigazione e di adattamento, sia per ipotizzare scenari futuri.
Riepilogo report climatici
La numerazione segue un ordine temporale in base a quando è stato pubblicato il report.
| N | Titolo | N | Titolo | |
| 1 | Report meteo-climatico 2023-2024 Alpi | 2 | Il clima nell’alto Finnmark | |
| 3 | 4 |
Mappa delle stazioni
Struttura dei report
Ogni articolo descrive in forma sintetica i risultati di elaborazioni numeriche fatte sulla base di dati acquisiti da una o più stazioni meteorologiche. Ne deriva una serie di indagini, sia locali sia regionali, utili a comprendere meglio il clima che cambia.
Per queste elaborazioni si utilizzano i dati provenienti dalle stazioni meteorologiche ufficiali, gestite per quanto riguarda l’Italia dalle varie regioni e provincie autonome e, per quanto riguarda gli altri stati, dagli enti preposti a questo servizio. Questi dati sono disponibili in forma gratuita accedendo ai vari portali dedicati.
La metodologia applicata è frutto di alcuni decenni di analisi climatiche effettuate dallo scrivente, seguendo le raccomandazioni delle più autorevoli istituzioni sulla materia (vedi “Principali riferimenti bibliografici” di seguito), nonché applicando gli aggiornamenti ed i progressi di tutta la comunità scientifica internazionale pubblicati sulle più importanti riviste del settore.
Spero che l’idea e il “format” siano di vostro gradimento e vi auguro una buona lettura.
Principali riferimenti bibliografici
- Barry R.G. (2008) – Mountain weather and climate. Cambridge University Press, New York, pp 506
- Barry R., Gan T.Y. (2011) – The Global Cryosphere. Past, Present and Future. Cambridge University Press, New York, pp 472
- Barry R.G., Blanken P.D. (2016) – Microclimate and local climate. Cambridge University Press, New York, pp 316
- Broll G., Keplin B. (2005) – Mountain Ecosystems. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp 354
- Dabernig M., Mayr G. J., Messner J. W., Zeileis A. (2017) – Spatial ensemble post-processing with standardized anomalies. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 143, 909-916
- French H.M. (2018) – The Periglacial Environment, Wiley Blackwell, Chichester, pp 563
- Gilbert R.O. (1987) – Statistical Methods for Environmental Pollution Monitoring. Van Nostrand Reinhold Company Inc., New York, USA, pp 336
- Gocic M., Trajkovic S. (2013) – Analysis of changes in meteorological variables using Mann-Kendall and Sen’s slope estimator statistical tests in Serbia. Global and Planetary Change, 100, 172-182
- Holtmeier FK. (2009) – Mountain Timberlines, Springer Science, pp 437
- Körner C. (2012) – Alpine Treelines, Springer, Basel, pp 220
- Kottek M., Grieser J., Beck C., Rudolf B., Rubel F. (2006) – World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated. Meteorologische Zeitschrift, 15 (3), 259-263
- Pettitt A.N. (1979) – A non-parametric approach to the change-point problem. Journal of the Royal Statistical Society, 28 (2), 126-135
- Rubel F., Brugger K., Haslinger K., et al. (2017) – The climate of the European Alps: Shift of very high resolution Köppen-Geiger climate zones 1800–2100. Meteorologische Zeitschrift, 26 (2), 115–125
- Sen P.K. (1968) – Estimates of the regression coefficient based on Kendall’s tau. Journal of the American Statistical Association, 63 (324), 1379-1389
- Stahr A., Langenscheidt E. (2015) – Landforms of High Mountains. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp 158
- Stepanek P. (2007) – AnClim, Software for time series analysis
- Wilks D.S. (2020) – Statistical methods in the atmospheric sciences. Fourth Edition, Elsevier, Oxford, pp 805
- World Meteorological Organization (2007) – The role of climatological normal in a changing climate. WMO-TD No. 1377, Geneva, Switzerland
- World Meteorological Organization (2009) – Guidelines on Analysis of extremes in a changing climate in support of informed decisions for adaptation. WMO-TD No. 1500, Geneva, Switzerland
- World Meteorological Organization (2017) – WMO Guidelines on the Calculation of Climate Normals. WMO No. 1203, Geneva, Switzerland
- World Meteorological Organization (2018a) – WMO Guide to Climatological Practices. WMO-No. 100, Geneva, Switzerland
- World Meteorological Organization (2018b) – WMO Guide to Instruments and Methods of Observation. WMO-No. 8, Geneva, Switzerland
Abbreviazioni utilizzate nei report
TM: Valore medio della temperatura (°C)
TMhom: temperatura media omogeneizzata (°C)
TN: Valore minimo della temperatura (°C)
TX: Valore massimo della temperatura (°C)
TNn: Minimo valore estremo della TN (°C)
TXx: massimo valore estremo della TX (°C)
DD: gradi-giorno, calcolati mediante sommatoria degli scarti dei valori positivi giornalieri: DD = Σ(TX-T), quando TX >0 °C e con T = 0 °C
ID: numero di giorni di gelo, cioè quando TX ≤0 °C
FD: numero di giorni con gelo, cioè quando TN ≤0 °C
FF: numero di giorni senza gelo, cioè quando TN >0 °C
P: Precipitazione totale, pioggia e neve fusa (mm)
PD: Numero di giorni con precipitazioni
S: Massima altezza di neve al suolo (cm)
SD: Numero di giorni con presenza di neve al suolo
 Immagine in evidenza: particolare di una stazione meteorologica automatica attuale, nello specifico la stazione “Rifugio Gastaldi”, ubicata nel bacino glaciale della Bessanese, a 2659 m s.l.m. e inserita nella rete di stazioni gestite da ARPA Piemonte (qui i dati online). A fianco, un’immagine complessiva della stazione, in cui è possibile identificare, sulla sinistra, il pannello solare necessario alla ricarica delle batterie utili per tenere attiva l’acquisizione e la trasmissione dei dati; poco a destra del pannello, il doppo radiometro per la misura della radiazione solare globale e della radiazione solare riflessa; al centro in alto, il pluviometro per la misura delle precipitazioni liquide e, in basso, l’antenna; a destra del pluviometro, il contenitore dove convergono i cavi provenienti dai diversi sensori e le relative schede elettroniche e, sopra, i due sensori di velocità e direzione del vento; a destra del palo lo schermo protettivo contenente il sensore di temperatura dell’aria e, ancora più a destra il braccio e il sensore a ultrasuonni per la misura dell’altezza di neve al suolo. Sullo sfondo, l’Uja di Bessanese (3620 m). Per una visione a 360 gradi di questo bacino consulatre la webcam del CNR-IRPI.
Immagine in evidenza: particolare di una stazione meteorologica automatica attuale, nello specifico la stazione “Rifugio Gastaldi”, ubicata nel bacino glaciale della Bessanese, a 2659 m s.l.m. e inserita nella rete di stazioni gestite da ARPA Piemonte (qui i dati online). A fianco, un’immagine complessiva della stazione, in cui è possibile identificare, sulla sinistra, il pannello solare necessario alla ricarica delle batterie utili per tenere attiva l’acquisizione e la trasmissione dei dati; poco a destra del pannello, il doppo radiometro per la misura della radiazione solare globale e della radiazione solare riflessa; al centro in alto, il pluviometro per la misura delle precipitazioni liquide e, in basso, l’antenna; a destra del pluviometro, il contenitore dove convergono i cavi provenienti dai diversi sensori e le relative schede elettroniche e, sopra, i due sensori di velocità e direzione del vento; a destra del palo lo schermo protettivo contenente il sensore di temperatura dell’aria e, ancora più a destra il braccio e il sensore a ultrasuonni per la misura dell’altezza di neve al suolo. Sullo sfondo, l’Uja di Bessanese (3620 m). Per una visione a 360 gradi di questo bacino consulatre la webcam del CNR-IRPI.